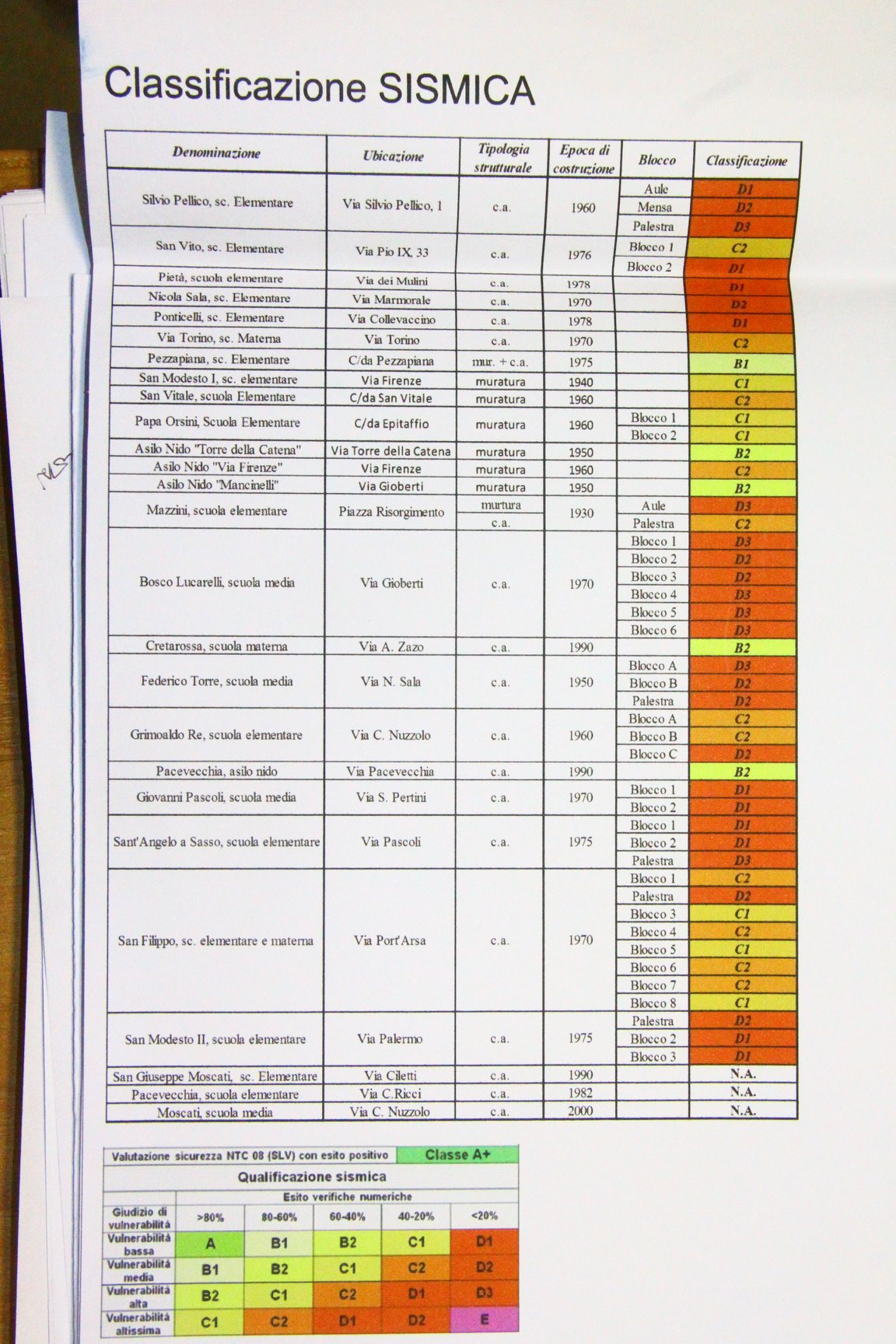Sinistro, eccentrico, morboso: Mario Praz, collezionista di solitudini

Travelling. Empire forniture», così venivano indicati gli svaghi di Mario Praz nella sua voce sul Who’s Who. Viaggiare e collezionare antiquariato, con una predilezione per lo stile Impero. Poche parole per riassumere la passione di una vita; opere d’arte che restano, certo, ma anche un ecosistema di conoscenza, ricordi e incontri destinato a scomparire quando cala il sipario, si fa buio e gli occhi non vedono più.
Che quello di Praz per l’antiquariato fosse vero amore non ci sono dubbi, basti pensare alla cura con cui scrive della sua collezione ogni volta che ne ha l’occasione, indugiando sui dettagli con la tenerezza di un raffinato maniaco. Un legame a tal punto definitivo che nelle pagine di La Casa della Vita l’autobiografia si riflette nella descrizione degli oggetti d’arte dell’abitazione di via Giulia, in uno strano transfert fra individuo e arredamento. Insomma, a modo suo anche la casa di Praz è una casa stregata, e in molti sono certi che la sua ombra si muova ancora silenziosa tra le cere policrome e i candelabri d’argento.
Pensando a Praz viene naturale immaginarlo solitario e spaventato dagli altri, rifugiato in una torre d’avorio dove il tempo si ferma e non si sentono voci, in quella dead life che la ex-moglie gli rimproverava. Forse è tutto vero, ma non dobbiamo pensare che certe scelte siano piacevoli scorciatoie e non è detto che amare le cose sia più facile che amare le persone. Non è un caso che il Professore citasse spesso Jiří Orten e la sua visione dell’amore bugiardo degli oggetti:
«Sarai il più abbandonato, quando le cose ti abbandoneranno. Le cose non domandano: dicono di sì a tutto. Le cose sarebbero delle magnifiche amanti».
Certo è che simili passioni determinano incomprensioni, giudizi, persino accuse, e non tutti seppero apprezzare l’intensità di questo hobby. Alcuni lo trovarono eccentrico, altri patologico, altri ancora sinistro e morboso. Fu anche il parossismo di questa passione, che portava Praz ad avere «le stanze piene e le tasche vuote», a contribuire alla creazione di una inquietante aura attorno alla sua figura. In fondo, i veri solitari non piacciono mai e non si può accettare che un uomo viva intrattenendo simili relazioni con oggetti apparentemente inanimati.
Il caustico Cyrill Connelly – il “Palinuro” della Tomba Inquieta – in una recensione beffarda intitolata The House of Antilife dileggiò le lunge e precise descrizioni di Praz: il libro gli parve un «tour de force della scocciatura» e l’anglista, con il suo «occhio di formica», gli sembrava avere rispetto ai suoi oggetti «un eccessivo senso della loro importanza in relazione a sé stesso e viceversa». Ma Connelly era troppo distratto dalla mondanità per giungere al cuore delle cose e, del resto, non avrebbe neanche voluto pagare il prezzo di una passione che costa una vita. Il Professore, dal canto suo, non si scompose più di tanto: da perfetto innamorato incassò le critiche, sorrise bonariamente e si fece scivolare tutto addosso; certo di sapere dove stava la verità e risoluto nel non mettere in discussione neanche per un istante la qualità dei suoi venerati oggetti d’arte.
In effetti, il rapporto tra Praz e il proprio appartamento meticolosamente arredato non manca di un certo interesse psicoanalitico. Significativo in questo senso il passaggio della postfazione alla riedizione della Casa della Vita, in cui il Professore descrive il disamore nei confronti del suo appartamento dopo un tentativo di furto. Il ladro viene messo in fuga e non riesce a rubare niente, ma la casa è stata profanata, le virginali stanze offese:
«il tempio era stato violato, né esisteva rito prescritto per riconsacrarlo […] quell’effrazione aveva cambiato il carattere della casa, vi aveva fatto passare sopra il soffio della morte».
L’incantesimo si era rotto, non tanto rispetto alla collezione, con cui era stato stretto un patto incorruttibile, ma con le mura dell’abitazione. Praz, di lì a poco, avrebbe deciso il trasloco nel nuovo appartamento di Palazzo Primoli, dove il rituale sarebbe ricominciato da capo per non finire mai.
Una così alta considerazione di quella “Empire forniture” non poteva poi non espandersi anche agli antiquari, coloro che rendono possibile la sublimazione di un oggetto da avanzo dimenticato a opera d’arte.
Praz riconosce i meriti della categoria con arguzia e onestà, riportando aneddoti e testimonianze curiose (tra i molti nomi anche quello di Fabrizio Apolloni, il cui figlio Marco Fabio, a testimonianza di un profondo legame tra antiquariato e letteratura, è autore di un eccezionale romanzo, Il mistero della locanda Serny, finalista al Premio Strega del 2004). Secondo il Professore, il magico potere dei mercanti d’arte antica sarebbe quello di rendere nuovo il vecchio «illuminando il valore storico e artistico d’un opera antica sì da renderla appetibile ai moderni» e, al contrario, vecchio il nuovo «dissimulando tutto quello che il restauro e l’abile interferenza moderna hanno aggiunto». In un certo senso gli antiquari agiscono nel tempo, negando l’hic et nunc dell’economia moderna e, chissà, forse è proprio questo il motivo di una certa diffidenza che talvolta viene loro riservata.
Inoltre, Praz non teme di affermare che il mondo della cultura ha spesso guadagnato più dalle scoperte di avventurosi antiquari che non dalle elucubrazioni di sedentari studiosi. Il motivo è semplice, laddove un filologo può dilungarsi in pagine e pagine di congetture strampalate senza rischiare che la spesa della carta, l’antiquario paga di persona i suoi sbagli, rimettendoci il proprio patrimonio. Ho sorriso leggendo queste righe: mio padre è un antiquario e, da quando sono bambino, sento spesso ripetere queste parole secondo diverse varianti (tra cui la più gettonata, quella in cui si menziona il didietro e i rischi che esso corre).
Felice Presta